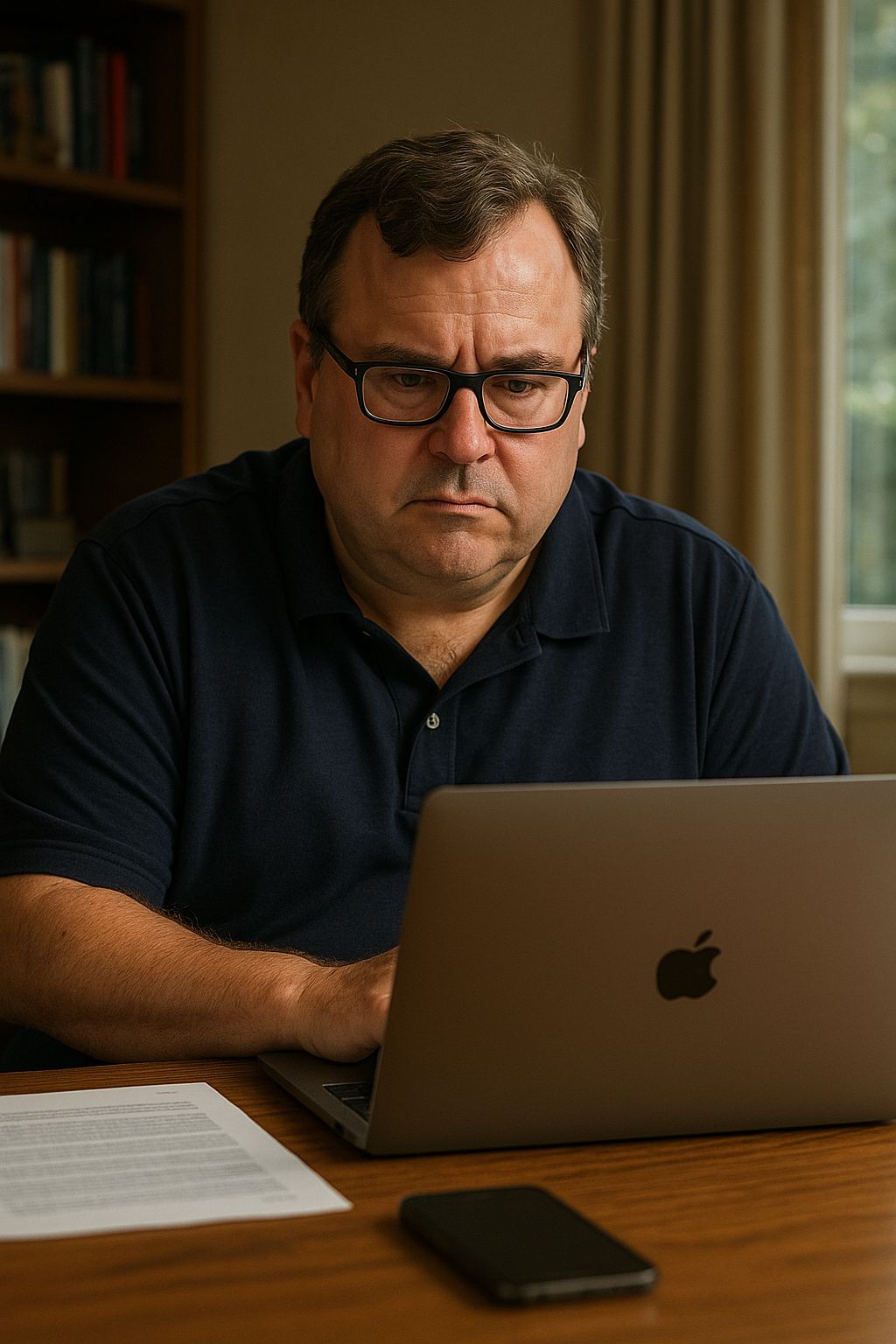Quando Reid Hoffman, fondatore di LinkedIn, investitore miliardario e membro del consiglio di amministrazione di Microsoft, racconta come utilizza l’intelligenza artificiale nella sua vita quotidiana, le sue parole non sono solo aneddoti personali. Sono una finestra su come persino i protagonisti della Silicon Valley, che hanno contribuito a plasmare il mondo digitale, vivono la transizione verso un futuro in cui l’AI è non solo uno strumento di lavoro, ma un compagno di pensiero.
In un episodio recente del podcast Moonshot, Hoffman ha rivelato che il suo utilizzo dell’AI gli costa circa 650 dollari al mese. Non si tratta di un trattamento speciale riservato al suo status, come molti avrebbero immaginato vista la sua vicinanza ad OpenAI e a Microsoft. Al contrario, ha spiegato di doversi abbonare ai piani più costosi di diversi servizi, perché solo questi offrono le funzionalità avanzate di cui ha bisogno, in particolare il cosiddetto Deep Research, la capacità dei modelli di scavare a fondo in un argomento e produrre risposte strutturate e ricche di contenuto.
Il suo metodo di lavoro parte quasi sempre da una domanda complessa: un quesito di ricerca che diventa la base di un progetto. L’AI restituisce non poche righe, ma risposte che possono arrivare a una pagina e mezza di testo, dense di argomenti e prospettive. A quel punto Hoffman legge, riflette, inizia a costruire il percorso del progetto. È un processo che assomiglia più a una collaborazione intellettuale che a una semplice interrogazione di un motore di ricerca.
I costi di questo approccio derivano dalla somma di diversi abbonamenti. ChatGPT Pro, ad esempio, costa 200 dollari al mese. Gemini, nella sua versione premium, ne costa 255. Grok-4 Heavy, l’alternativa proposta da xAI, arriva a 300 dollari. A questo si aggiunge Copilot, il servizio di Microsoft integrato con Office 365, che costa 99 dollari all’anno ma che, con le licenze collegate, porta il totale a un livello superiore. La cifra finale di circa 650 dollari al mese appare imponente, ma per chi ha un patrimonio netto stimato da Forbes in 2,5 miliardi di dollari, rappresenta un investimento personale nella propria produttività e nella propria capacità di visione.
Ciò che colpisce non è tanto la spesa, quanto l’approccio. Hoffman non si affida a un solo modello, ma usa più chatbot in parallelo, confrontando le loro risposte. È una pratica comune tra utenti avanzati e sviluppatori, una sorta di controllo incrociato che permette di ridurre errori, bias e “allucinazioni” tipiche dei singoli modelli. Nella programmazione, ad esempio, questa strategia si rivela particolarmente utile: se due AI propongono soluzioni simili a un problema di codice, la fiducia nella correttezza della risposta cresce esponenzialmente.
Non è un caso che lo stesso principio stia alla base delle nuove generazioni di AI. Google, con il suo Gemini 2.5 Deep Thinking, ha introdotto un sistema che confronta più risposte al suo interno prima di proporre quella finale. OpenAI, con il futuro Universal Verifier, seguirà una strada simile. L’idea è che non basta generare contenuti: occorre anche verificarli, filtrarli, consolidarli. Hoffman, nella sua pratica personale, anticipa ciò che sta diventando lo standard industriale.
Ma l’intervento di Hoffman nel podcast non si è limitato ai dettagli tecnici. Ha affrontato una gamma ampia di temi: l’impatto dell’AI sul lavoro e sull’istruzione, il futuro della robotica e della guida autonoma, il rischio (e l’opportunità) della superintelligenza, il ruolo della regolamentazione e persino le sfide energetiche connesse a questo nuovo paradigma tecnologico. Su tutti questi aspetti, ha mantenuto una visione ottimista. Per lui, la priorità non è limitare l’AI attraverso norme rigide, ma migliorare continuamente i modelli, riducendo gradualmente errori e imperfezioni. La regolamentazione, suggerisce, deve accompagnare, non soffocare.
Il ritratto che emerge è quello di un imprenditore che non solo investe nell’AI come settore economico, ma che la utilizza come strumento quotidiano, come lente attraverso cui osservare e interpretare il mondo. Se persino figure con le sue competenze e risorse scelgono di pagare somme significative per accedere ai modelli migliori, ciò dimostra quanto la partita dell’AI non sia più confinata ai laboratori di ricerca: è ormai una questione personale, di produttività, di creatività.
In fondo, il messaggio di Hoffman è chiaro: l’intelligenza artificiale è già parte integrante della vita dei leader tecnologici, e lo diventerà presto per tutti noi. La differenza, forse, sarà nel prezzo che ciascuno sarà disposto — o in grado — di pagare per avere al proprio fianco non un assistente qualunque, ma un compagno di pensiero capace di rendere il lavoro e la vita più ricchi di possibilità.