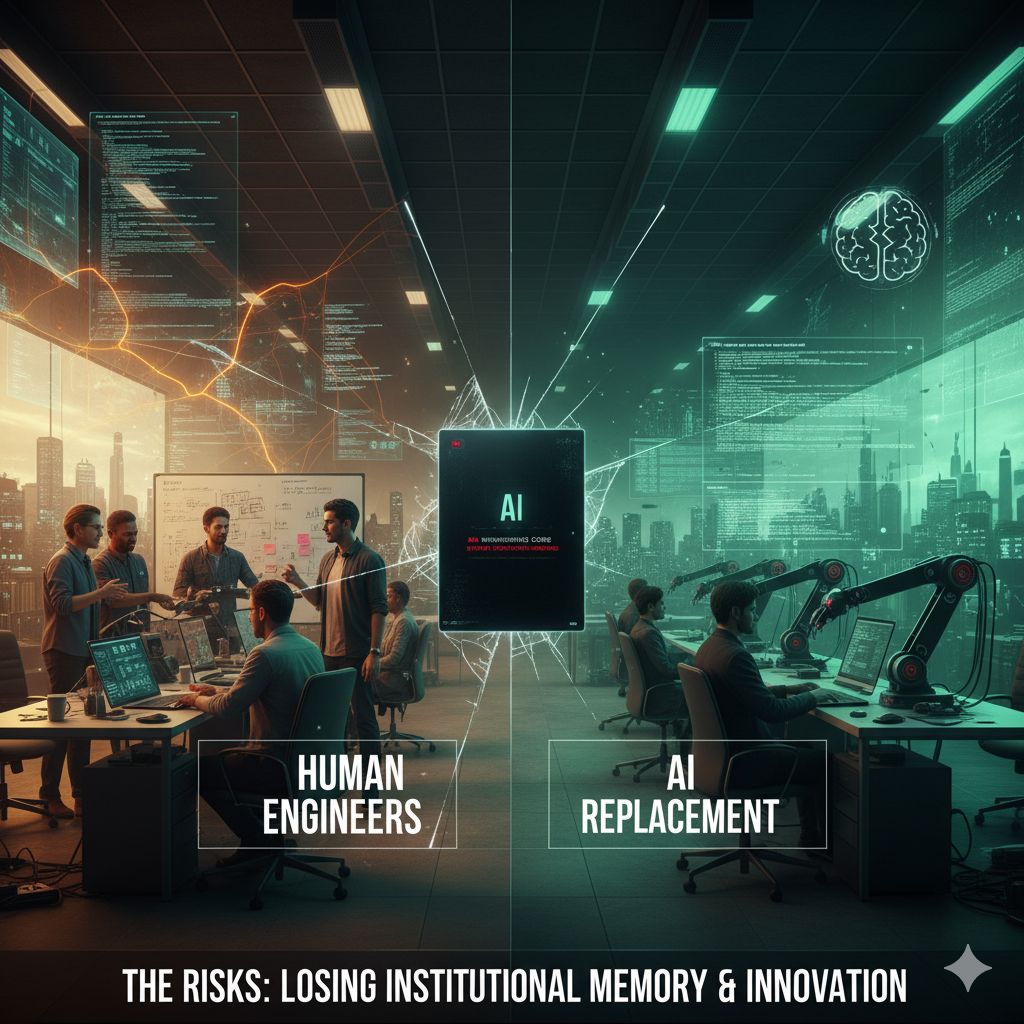L’ascesa dei modelli di Intelligenza Artificiale generativa, capaci di scrivere codice, progettare architetture e persino eseguire il debugging, ha innescato una fantasia audace nei corridoi del management aziendale: l’idea di poter sostituire interamente il personale ingegneristico con sistemi di AI. Sebbene la promessa di una produttività ineguagliabile e di una drastica riduzione dei costi sia allettante, una riflessione pragmatica rivela che questo scenario utopico nasconde un ventaglio di rischi operativi e strategici che potrebbero non solo annullare i benefici attesi, ma mettere a repentaglio l’intera resilienza e capacità innovativa di un’organizzazione.
Il primo e più critico elemento che verrebbe perso con l’allontanamento degli ingegneri umani è la memoria istituzionale profonda e la conoscenza del contesto. Gli ingegneri non si limitano a scrivere codice; essi comprendono il perché di ogni riga. Sanno come i sistemi legacy si interconnettono, quali compromessi sono stati fatti decenni fa e le insidie nascoste in specifiche sezioni del codice. Un’AI, per quanto sofisticata, è cieca a questa storia. Essa opera su istruzioni fornite e sul training data, ma non possiede la comprensione tacita e l’intuizione derivante da anni di esperienza diretta nella trincea operativa.
Affidando la manutenzione e lo sviluppo esclusivamente all’AI, le aziende rischierebbero di accumulare un enorme debito tecnico non riconosciuto. Un’AI, ottimizzando per la soluzione più efficiente o veloce basata sui suoi parametri interni, potrebbe involontariamente creare architetture più complesse, difficili da mantenere o interamente dipendenti da librerie proprietarie specifiche. Senza ingegneri umani per monitorare e sfidare le decisioni dell’AI, questo debito si accumulerebbe in silenzio, trasformando la piattaforma tecnologica in una scatola nera indecifrabile e non manutenibile, pronta a crollare al primo vero shock del sistema.
Il secondo rischio è intrinsecamente legato alla natura stessa dei modelli di AI: essi sono eccellenti nell’ottimizzazione incrementale e nell’esecuzione di compiti noti, ma sono intrinsecamente poveri nell’innovazione radicale. L’ingegneria di punta non è solo risoluzione di problemi; è formulazione di problemi, esplorazione di vie non convenzionali e pensiero laterale su come un sistema potrebbe funzionare diversamente. L’innovazione spesso richiede di sfidare le ipotesi esistenti, un’azione che va contro la logica di un modello di AI addestrato su schemi e soluzioni precedenti.
Se un’azienda affida l’80% delle sue funzioni ingegneristiche a un’AI, si ritroverebbe con un sistema che replica diligentemente e perfeziona ciò che è già noto, ma che sarebbe totalmente incapace di ideare la prossima grande svolta tecnologica o di reagire in modo creativo a un cambiamento dirompente del mercato. L’AI, in questo scenario, non sarebbe un motore di crescita, ma un freno all’evoluzione, condannando l’azienda a inseguire anziché a definire lo standard del settore.
Infine, un’impresa che licenzia i suoi ingegneri si condanna a una vulnerabilità operativa estrema. Immaginiamo uno scenario in cui un bug critico si verifica nel sistema centrale di AI Engineering stesso. Chi interverrebbe? Non ci sarebbe più il capitale umano con le competenze necessarie per intervenire direttamente sul codice sorgente o per risolvere un’emergenza che l’AI non è stata addestrata a gestire. L’azienda si ritroverebbe in una situazione di totale dipendenza dal suo fornitore di AI o dal modello stesso.
Questa dipendenza si manifesta anche nel rischio di monocultura tecnologica. Se tutti i sistemi vengono scritti da un unico modello di AI basato su un framework specifico, l’azienda si esporrebbe a vulnerabilità di sicurezza e difetti di progettazione comuni e sistemici. La diversità di approccio e di prospettiva, un tempo garantita da un team eterogeneo di ingegneri, scomparirebbe, lasciando l’intera infrastruttura esposta a un singolo punto di fallimento catastrofico.
Mentre l’AI è uno strumento inestimabile per aumentare la produttività e l’efficienza degli ingegneri umani, l’idea di sostituirli interamente rappresenta un salto nel buio. L’ingegneria è una disciplina che fonde logica, esperienza storica e creatività. La sostituzione totale non è un percorso verso l’ottimizzazione, ma una rinuncia strategica alla capacità di innovare, risolvere i problemi complessi e, in ultima analisi, garantire la sopravvivenza a lungo termine dell’impresa. L’AI è il copilota ideale, ma l’azienda ha ancora bisogno del suo capitano umano al timone.