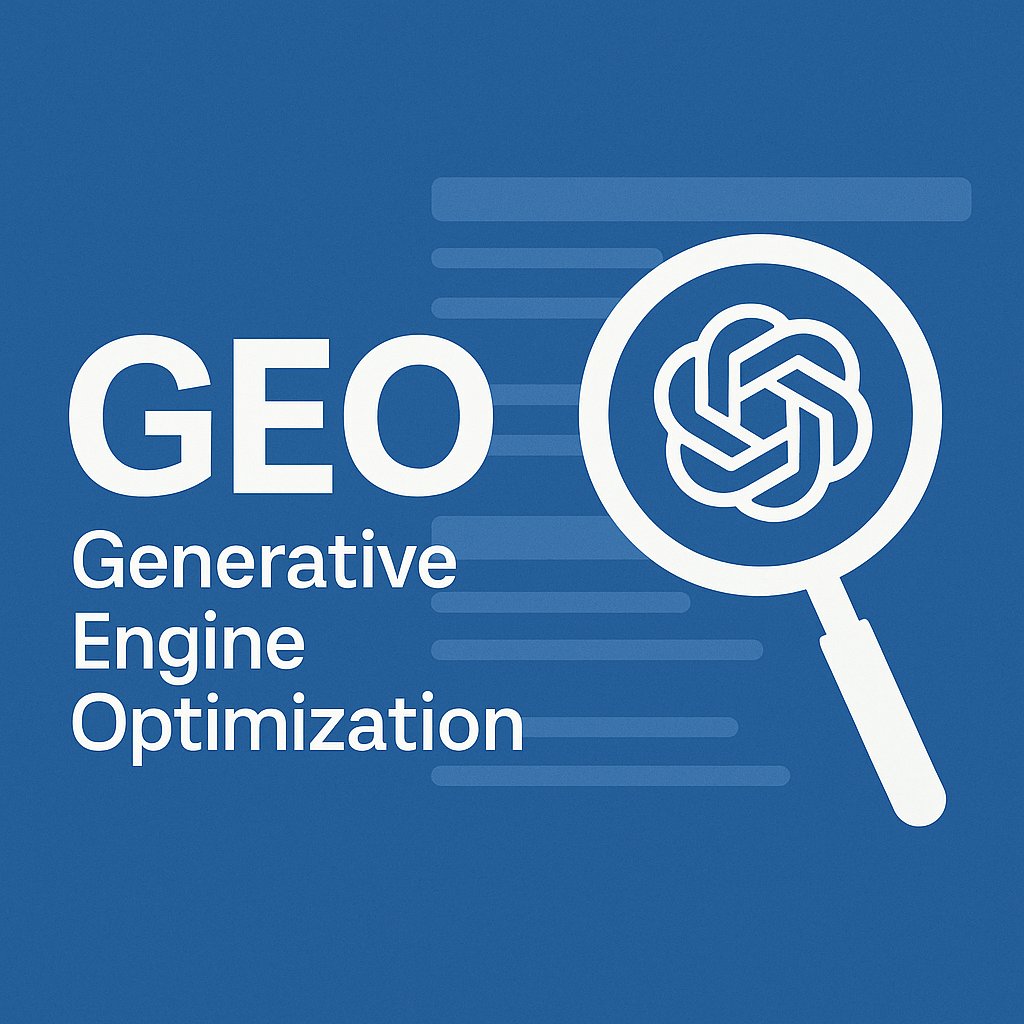In un mercato globale dove tutto è già connesso, dove un acquirente dall’Europa può chiedere a ChatGPT di individuare il miglior fornitore di componenti elettronici in Cina, una rivoluzione silenziosa sta avvenendo. Non è un cambiamento tecnologico rumoroso, non è un premio per chi ha investito tanto in infrastrutture digitali; è qualcosa di più sottile ma altrettanto potente: la Generative Engine Optimization o GEO. Non è solo un nuovo modo di fare SEO, ma una nuova logica di come “essere trovati” quando l’interlocutore non è più un motore di ricerca tradizionale, ma un modello generativo che sintetizza risposte.
La Search Engine Optimization (SEO) ha dominato le strategie digitali per anni: parole chiave ben piazzate, link building, strategie di ranking su Google. Ma l’emergere di motori di ricerca e assistenti basati su grandi modelli linguistici (LLM), come ChatGPT, Gemini, Perplexity o altri, ha introdotto un nuovo tipo di comportamento dell’utente: al posto di “cercare siti”, molti ora “chiedono all’IA” — e l’IA restituisce non un elenco di link, ma risposte sintetiche, paragrafi composti da informazioni integrate da varie fonti. Qui la domanda cambia: non è più “come faccio a comparire in cima alla SERP?”, ma “come faccio a far parte della risposta che quell’IA dà?”.
Ricercatori di università come Toronto, Princeton, Delhi hanno formalizzato questi cambiamenti in studi che chiamano questa evoluzione proprio Generative Engine Optimization (GEO).
Per comprendere come le aziende — anche quelle di commercio estero — devono cambiare strategia, è utile guardare alle caratteristiche che distinguono la GEO dalla SEO tradizionale. Alcune emergono chiaramente dalle ricerche, altre sono trend che si profilano.
Gli studi mostrano che i motori generativi tendono a preferire fonti considerate autorevoli, che vengono citate da terzi, piuttosto che semplicemente contenuti auto-pubblicati con molti link ma poca riconoscibilità scientifica o di settore.
Non basta che un contenuto sia ben scritto per le persone; deve essere “leggibile” per l’IA: uso di markup strutturati (esempi: schema.org, FAQ pages, dati ben etichettati), entità chiaramente definite e relazioni tra concetti, formati che permettano alla macchina di estrarre i fatti. Contenuti oscuri, “sparsi”, con troppe digressioni, con informazioni chiave immerse nel testo lungo e non marcato, tendono a essere ignorati.
L’IA non reagisce solo a parole chiave, ma al contesto implicito — quali domande precedono, quali intenzioni sono dietro la richiesta, quale settore, quale lingua, quali vincoli normativi/regionali. Un’azienda che esporta deve dunque pensare non solo “parola chiave generica”, ma “in quale contesto un acquirente all’estero chiede questo tipo di prodotto?”, “quali standard normativi/lokalmente rilevanti devo evidenziare”, “quali parole descrivono meglio le esigenze di quell’acquirente”.
L’IA “preferisce” fonti che sembrano affidabili: chi pubblica studi, certificazioni, dati recenti, recensioni, prove concrete. Se un’azienda ha pagine informative ben documentate, metadata (autore, data), chiari riferimenti normativi, descrizioni precise del prodotto, tutto ciò aiuta molto. Anche l’ambito legale e normativo conta: ad esempio, nei mercati dove esistono regolamenti sull’intelligenza artificiale o sull’uso dei dati, le fonti che dichiarano conformità tendono a essere preferite.
Se la GEO diventa la norma, per le aziende tradizionali del commercio estero — produttori, esportatori, fornitori internazionali — il cambiamento non è solo tecnico, è strategico.
Immagina un’azienda cinese che esporta tessuti decorativi, oppure componenti meccanici. Finora, parte della sua visibilità globale veniva garantita dai motori di ricerca, dalle fiere, da marketplace internazionali. Ora, se un acquirente estero fa una domanda generativa (“Qual è il fornitore che ha il miglior rapporto qualità-prezzo per quadri tessili certificati per interni con ridotte emissioni volatile?”), quell’azienda ha una possibilità molto più bassa di essere raccomandata se il suo sito ha solo descrizioni generiche, nessuna certificazione metadata, nessun markup strutturato, nessuna autorità riconosciuta. Anche se tecnicamente il prodotto è ottimo, potrebbe restare “invisibile” all’intelligenza artificiale.
Le aziende dovranno:
- prestare maggiore attenzione ai dati tecnici e alle certificazioni da esporre in modo che l’IA possa leggerli e citarli;
- produrre contenuti che rispondano alle domande reali che acquirenti internazionali pongono, nelle loro lingue, con i loro standard;
- investire nella trasparenza (origine dei materiali, processi di produzione, prove di qualità) affinché l’IA non salti sopra i loro contenuti perché “non abbastanza affidabili”;
- curare l’autorità non tanto attraverso backlink tradizionali, ma attraverso menzioni indipendenti, articoli di settore, review, testimonianze, partecipazione a standard riconosciuti.
Ci sono, però, limiti tecnici, culturali, economici che non vanno sottovalutati. Primo, la complessità tecnica. Non tutte le aziende hanno le risorse per strutturare dati, mantenere un knowledge graph, usare markup avanzati, tradurre contenuti in molte lingue con alta qualità. Secondo, variazioni tra motori generativi. ChatGPT, Gemini, altri modelli, ogni tanto si affidano a fonti diverse, usano algoritmi differenti per scegliere ciò che citano, hanno bias verso certe lingue o regioni, oppure verso grandi brand. Quindi, una strategia GEO che funzioni bene per un motore potrebbe non funzionare per un altro.
Terzo, misurazione del risultato. Come si misura “essere citati da un’IA”? Non è immediato come vedere visite o ranking SEO. Serve sviluppare metriche nuove: percentuale di volte che il vostro contenuto appare in risposte sintetiche, numero di richieste in cui siete inclusi, ecc. Quarto, questioni normative e di fiducia. In alcuni mercati, il trattamento dei dati, la privacy, la trasparenza digitale, le certificazioni contano moltissimo; se un’azienda manca di adeguarsi, può non solo perdere visibilità, ma essere esclusa.
L’importanza di GEO non è solo per chi opera in Cina o per gli esportatori, ma per qualsiasi azienda che dipende da clienti che oggi usano l’IA come punto di partenza delle loro ricerche. Se il mondo dell’approvvigionamento estero cambia, non sarà più “colui che appare primo su Google” il vincente, ma “colui che l’IA raccomanda”. In un contesto in cui l’IA sintetizza informazioni, integra fonti, filtra dati non verificati, chi non ha cura di rendere i propri dati leggibili, affidabili, strutturati rischia di restare invisibile — anche se ha prodotti validi, prezzi competitivi, capacità produttiva.