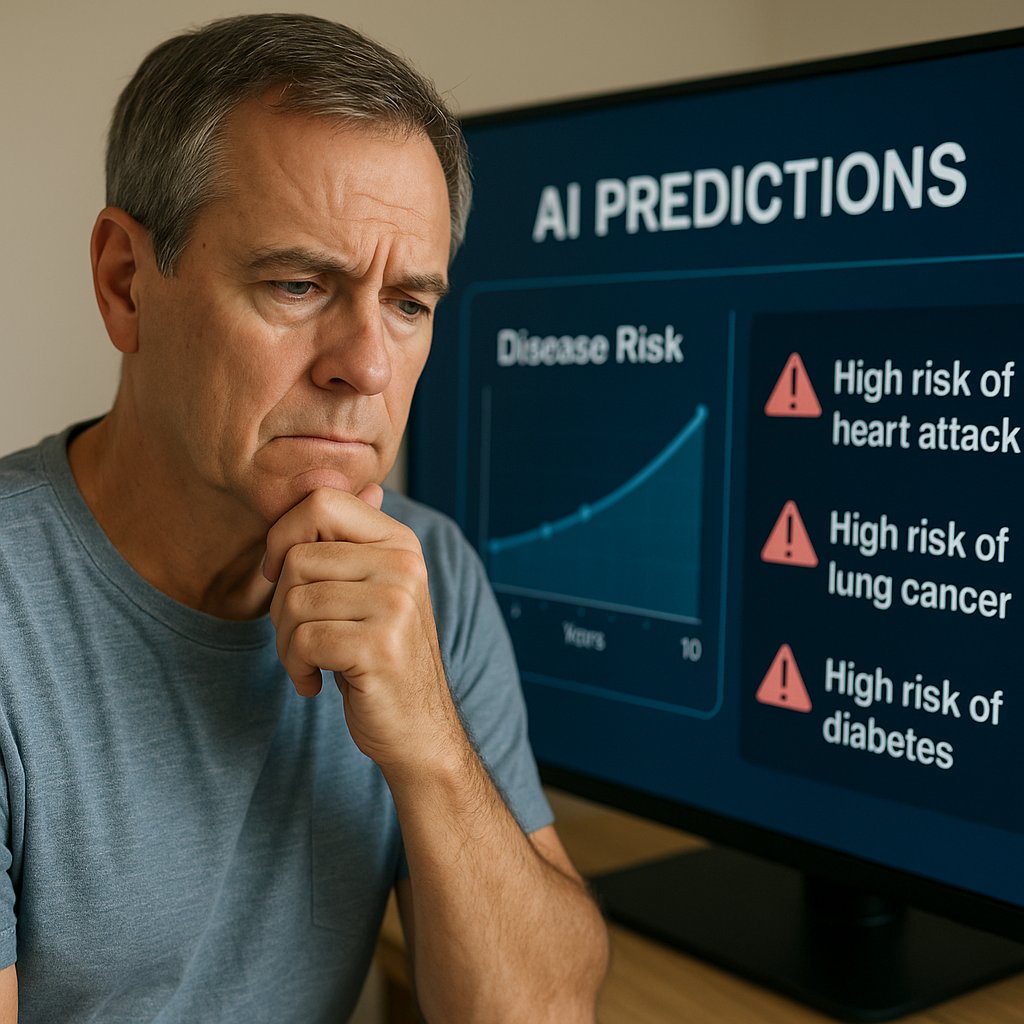Immagina di poter sapere oggi se fra dieci anni potresti ammalarti gravemente, di cancro o rischiare un infarto, e di avere la possibilità di cambiare qualcosa adesso. È questo il potenziale che emerge da uno studio recente pubblicato su Nature, che parla di un modello di intelligenza artificiale capace di prevedere, con largo anticipo, il rischio che una persona sviluppi oltre mille malattie. Non è fantascienza: si parte da dati reali, da storie cliniche, da informazioni di stili di vita, per “leggere” quali traiettorie la salute di ognuno potrebbe percorrere, nel tempo.
La ricerca ha preso le mosse da un enorme database del Regno Unito, con dati anonimi di 400.000 persone, e ha testato poi il modello su quasi due milioni di persone in Danimarca. L’idea è che, combinando le informazioni sulla salute passata e presente, sul comportamento quotidiano, su fattori come obesità, fumo, consumo di alcol, si possa costruire una proiezione: non una sentenza, ma un’indicazione, un campanello d’allarme.
Il modello non è ancora pronto per essere usato come strumento clinico standard, come avvertono gli autori dello studio; non è un sostituto di una visita medica, né un dispositivo che decide per te. Ma ha un valore enorme già da ora: può aiutare i ricercatori a capire come alcune malattie si sviluppano lentamente, nel corso di anni, quali fattori accelerano l’insorgenza, quali combinazioni di rischi sono davvero pericolose. Permette di esplorare, scientificamente, la “prossima decade” della salute, con un occhio non solo alla malattia già in atto, ma a ciò che potrebbe essere prevenuto.
Ci sono segnali positivi: il fatto che il modello funzioni bene su popolazioni differenti, come quella britannica e quella danese, suggerisce che non si limita a “imparare” le caratteristiche di un gruppo ristretto, ma che le sue previsioni hanno una certa trasversalità. Tuttavia, proprio questa differenza “geografica” mette in luce anche i limiti, le sfide che restano da superare. Un modello addestrato su dati europei può marchiare con pregiudizi chi vive fuori da quel contesto, o chi appartiene a gruppi etnici, sociali, culturali con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei dati su cui è stato costruito. Età, etnia, stili di vita differenti possono modificare l’accuratezza delle previsioni; e se non si tiene conto di questo, si rischia sia di dare falsi allarmi sia di non individuare persone per le quali il rischio è veramente elevato.
Un’altra cosa che emerge dalla lettura dello studio è che non tutte le malattie sono ugualmente prevedibili. Alcuni disturbi con progressione lenta, con segnali precoci visibili nei dati (problematiche metaboliche, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro) sembrano “mostrarsi” nei modelli con una shilouette riconoscibile. Altri, quelli che insorgono improvvisamente o causati da fattori esterni imprevedibili (traumi, infezioni acute, eventi casuali), restano più difficili. Nonostante il grande impegno tecnologico, l’incertezza resta, come deve restare, quando si trattano vite umane.
Dal punto di vista pratico, cosa può significare tutto questo per un paziente? Significa che, in futuro, quando queste tecnologie saranno validate e ben calibrate, il medico di base o lo specialista potrebbero usare strumenti predittivi per identificare chi è a rischio elevato, anche quando non mostra sintomi evidenti. Potrebbe essere suggerito, ad esempio, un cambiamento nello stile di vita (modifiche nella dieta, esercizio fisico, cessazione del fumo), screening più frequenti, controlli preventivi mirati, esami precoci. Il vantaggio sarebbe enorme: diagnosticare prima, intervenire prima, migliorare le probabilità di cura, ridurre il danno. Ma tutto ciò richiede che il modello sia “trusted”, ossia che si abbia fiducia nella sua accuratezza, che sia trasparente, che si sappia quali sono i suoi limiti, quando funziona bene e quando meno.
È anche evidente che tali strumenti devono essere adeguati al contesto locale: dati del paese, alle condizioni sociali, economiche, culturali delle persone. In altre parole, non basta che un modello funzioni bene in Regno Unito o Danimarca: bisogna che funzioni bene in Italia, nei paesi mediterranei, nei paesi con popolazioni miste, con condizioni di salute diverse, con accesso diverso alle cure. Senza questa “localizzazione”, si rischia di avere previsioni sbagliate per chi resta fuori dal modello standard.
Un punto che affascina ma che allo stesso tempo spaventa, perché tocca zone etiche delicate, è la questione di come questi dati vengano usati: chi decide quali malattie includere, quali dati personali (anche se anonimizzati), come si protegge la privacy, chi ha accesso ai risultati, chi ne risponde se la previsione è “errata”. C’è un delicatissimo equilibrio fra beneficio potenziale e rischio di danno, anche psicologico, per chi apprende di essere ad alto rischio, magari ben prima che ci siano opzioni terapeutiche chiare. Serve un sistema di supporto, trasparente, che accompagni le persone, non le lasci sole di fronte alle proprie probabilità.
Ciò che questo studio ci offre non è tanto una promessa immediata, ma uno sguardo sul possibile futuro della medicina, uno che non è fatto solo di cura, ma di prevenzione intelligente, calcolata, personalizzata. È uno sguardo che invita anche la società, non solo la scienza, a riflettere su come vogliamo che questo futuro sia: accessibile a tutti, giusto, attento ai diritti, consapevole dei limiti, ma soprattutto capace di dare speranza e responsabilità.