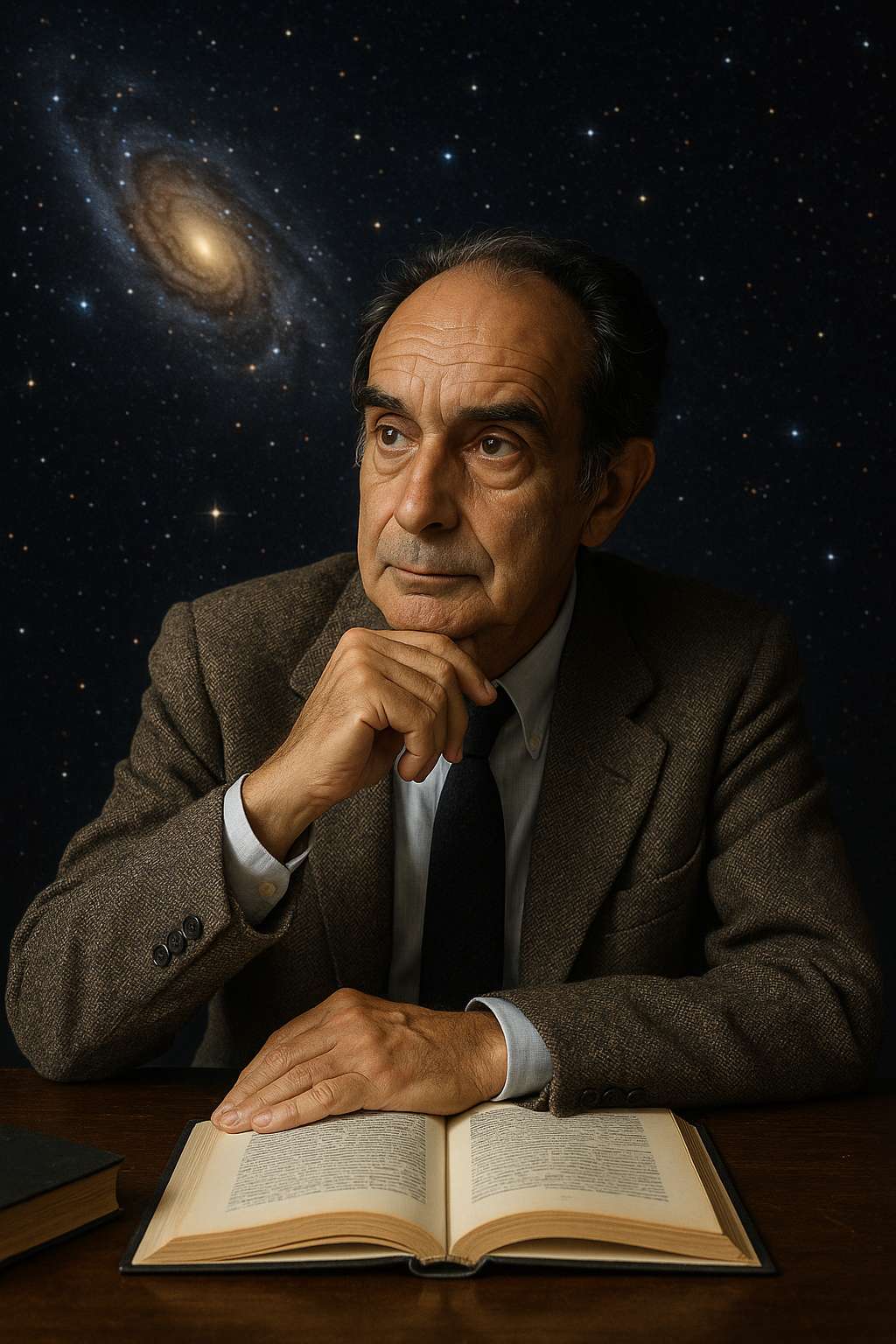È il 19 settembre del 1985 quando scompare Italo Calvino, uno dei grandi narratori del Novecento italiano. Ma se lo guardiamo con gli occhi di oggi, in un’epoca in cui le parole “fantascienza”, “intelligenza artificiale” e perfino “Star Trek” sono diventate parte del vocabolario popolare, Calvino emerge come una figura curiosamente contemporanea: non un pensatore che anticipa catastrofi tecnologiche, ma un tessitore di mondi e linguaggi che giocava con la scienza, l’immaginazione e l’ignoto.
Nel pezzo uscito su CorriereNerd si ricorda come Calvino, pur negando che le sue opere fossero “fantascienza” nel senso classico, abbia costruito con Le Cosmicomiche e Ti con zero narrazioni che anticipano temi cari alla cultura nerd. L’idea non è tanto quella del futuro visto come macchina, come progresso lineare: piuttosto, Calvino usava dati scientifici, intuizioni cosmologiche, teorie fisiche, per uscire da ciò che chiama “le abitudini dell’immaginazione”. Quegli elementi di scienza diventano nel suo racconto trampolini per il fantastico, per il mito, per la riflessione su quanto siamo piccoli, ma anche su quanto possiamo meravigliarci.
C’è un personaggio che incarna bene questa tensione: Qfwfq, voce narrante di molte storie in Cosmicomiche. Entità senza forma fissa, antica quanto l’universo, che ha visto nascere stelle, galassie, forse vita. Qfwfq è ciò che oggi potremmo definire quasi un intelligenza aliena, sfuggente, una metafora di ciò che la scienza suggerisce nei suoi momenti più astratti. Racconta la storia del cosmo non con tono accademico, ma con meraviglia, leggerezza, ironia: come farebbe un’entità extraterrestre che osserva la nostra specie curiosa, piena di paure e di speranze.
Nel guardare al suo lavoro oggi, gli appassionati di “nerdismo” vedono analogie con Star Trek — non soltanto per l’immaginazione cosmica, per il viaggio nello spazio, per l’idea di esplorazione — ma anche per il modo di combinare scienza e umanità. In Star Trek la fantascienza serve a riflettere sull’umano: le sfide morali, il contatto con l’ignoto, il progresso che può essere bene o male. Calvino, dal canto suo, non metteva astronavi dappertutto, ma portava il cielo, i numeri, i buchi neri, la velocità della luce come sfondo — e spesso come protagonista – delle sue storie, non per mostrarne la tecnica, ma per liberare l’immaginazione.
Quello che sorprende è come certe visioni sembrano oggi quasi normali, eppure in quegli anni erano radicali. Calvino mostrava che uno spicchio di scienza, un’idea cosmica, una teoria fisica, potevano diventare materiale poetico, e che usare questi elementi non toglieva profondità, ma la moltiplicava. Lui stesso diceva che il dato scientifico serve come “carica propulsiva”: non per spiegare il mondo nella misura dell’utile, ma per sfidare come pensiamo e immaginiamo il mondo.
C’è poi un aspetto che oggi diventa ancora più interessante: l’intelligenza artificiale o, più in generale, le macchine intelligenti, la tecnologia che simula, replica o immagina. Sebbene Calvino non abbia scritto di robot senzienti né di IA come le immaginiamo oggi, il suo interesse per il linguaggio, per la combinazione di elementi, per la struttura narrativa, per le regole latenti dietro la realtà, per la speculazione che diventa racconto: tutto questo si avvicina molto a ciò che l’IA, nella sua dimensione creativa, cerca di fare. Calvino rifletteva già sul rapporto fra realtà e racconto, su come le storie possano modellare mondi possibili, e su quanto l’immaginazione possa espandersi se liberata da vincoli narrativi convenzionali.
Rileggere Calvino vuol dire scoprire un autore che non viveva nella nostalgia del passato né nella fede semplice nel progresso: era, piuttosto, sospeso in un presente-possibile, fatto di domande, di speculazioni, di domande su che cosa significhi essere umani in un universo che sembra più grande, più misterioso, più sorprendente di quanto la nostra vita quotidiana suggerisca. Per chi ama la fantascienza, o cerca riflessioni sulle AI, Calvino offre spunti che non sono “anticipazioni tecnologiche” ma versi di meraviglia, che rendono le sfide del futuro non solo questioni di ingegneria ma anche di poesia.
Alla fine, l’eredità che Calvino lascia a chi oggi scrive, pensa, immagina è questa: non smettere di guardare il cielo, non accettare che la scienza sia solo strumento, ma chiederle cosa può farci vedere che non avevamo ancora visto, che non avevamo ancora pensato. E, soprattutto, non dimenticare che l’immaginazione non è fuga, ma il modo più potente che abbiamo per essere davvero liberi.